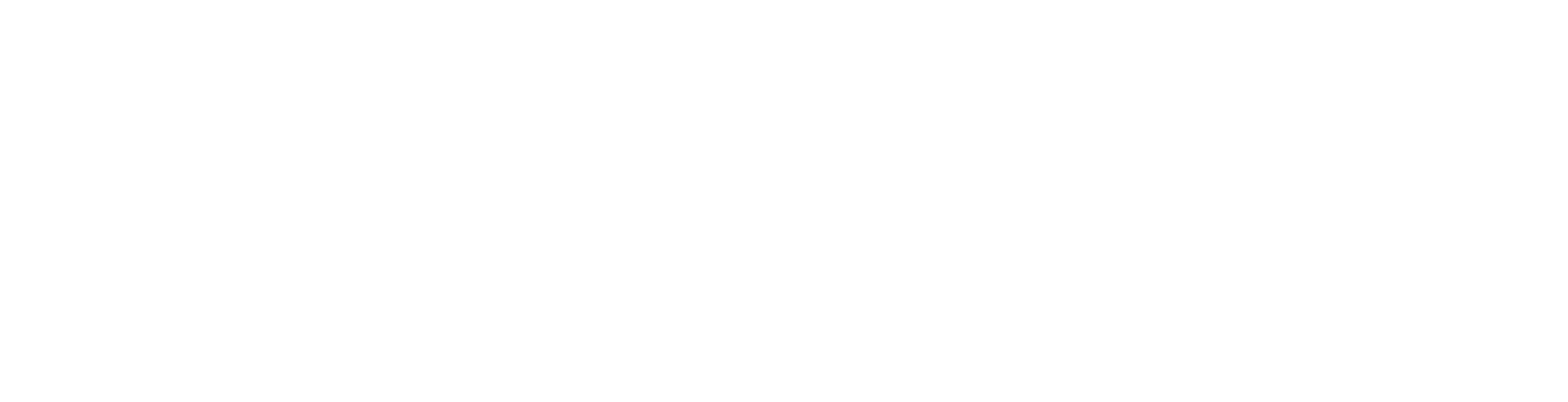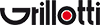Pubblichiamo quanto scritto dal procuratore capo di Rieti, Giuseppe Saieva, in occasione della ricorrenza della morte di Paolo Borsellino.
Ho incontrato una sola volta Paolo Borsellino con il quale ho scambiato alcune parole di conforto nella sagrestia della chiesa di San Domenico ai funerali di Giovanni Falcone. Viceversa ho avuto l’onore di conoscere Giovanni Falcone ed il privilegio di esserne amico, sin dal 1988 quando unitamente con altri trentacinque colleghi demmo vita al Movimento della giustizia costituendo una nuova corrente associativa all’interno dell’A.N.M.
Da allora e fino al maggio del 1992 con altri colleghi romani del neo costituito Movimento ho trascorso con lui quasi tutte tutte le serate in cui egli soggiornava a Roma.
Ci legavano le comuni origini siciliane, ma anche una assoluta intransigenza e una grande lealtà istituzionale; doti tutt’altro che apprezzate da molti colleghi che ebbero a ritorcere contro di lui ogni scelta; prima tra tutte quella di andare a dirigere l’ufficio degli Affari penali in quel ministero della Giustizia guidato dal socialista Claudio Martelli sotto il governo del democristiano Giulio Andreotti.
Non ho mai partecipato ad alcun evento commemorativo per non unire la mia voce a quella di coloro che avendo criticato, contestato, contrastato, osteggiato e perfino calunniato Falcone quando era in vita, non hanno fatto che celebrarne con nauseabonda ipocrisia le virtù dopo la sua morte. Ma si sa, per farsi apprezzare appieno ed incondizionatamente bisogna morire.
Basterebbe ricordare le critiche rivolte a Giovanni Falcone allorquando ebbe a cogliere l’occasione di passare agli Affari penali del Ministero allo scopo di suggerire quelle modifiche normative che secondo lui avrebbero consentito un coordinamento indispensabile per sconfiggere le organizzazioni mafiose.
Lo strumento da lui ideato, la direzione nazionale antimafia, fu subito accolto con freddezza e scetticismo. Falcone venne aspramente criticato da tutti quei colleghi che ritenevano una mera utopia la manifestata possibilità di potere realizzare strumenti idonei a contrastare le organizzazioni mafiose.
Ma dopo la strage di Capaci ebbero a convergere su Falcone parole di profonda ed incondizionata stima. Cessarono tutte le critiche.
Nessuno osò più affermare che “dentro i cassetti del Palazzo di giustizia c’erano abbastanza elementi per fare giustizia sui delitti di mafia”.
Nessuno continuò ad accusare Falcone di non dare il giusto valore alle versioni dei pentiti e di affidarsi solo alle prove fattuali. Nessuno ebbe più ad insinuare che Falcone avesse organizzato personalmente l’attentato all’Addaura.
E non ebbe ad insistere il collega che oggi guida una delle procure più importanti d’Italia nel definire la Dna una “ferraglia” che Falcone avrebbe voluto guidare personalmente.
Tacque pure quel componente del Csm in quota Pci che definì la Direzione nazionale antimafia (voluta da Falcone) «una grave lesione alle prerogative del parlamento e all’indipendenza della magistratura», oltre che un vero e proprio «disegno» per una «ristrutturazione neo-autoritaria».
Cessarono anche le critiche del più diffuso quotidiano romano che definì Falcone magistrato affetto da «febbre di presenzialismo» e lo invitò ad «abbandonare la magistratura», visto che ormai era in preda a una «eruzione di vanità»; la stessa che colpiva i «guitti televisivi».
Per contro, dopo la sua morte, fu avviata una inedita attività mediatica allo scopo di far pronunciare a Falcone “da morto” parole che in vita non aveva mai pronunciato e furono addolcite le proposte che aveva formulato in tema di separazione delle carriere e di revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale; argomenti cari a Falcone per i quali si cercò perfino di revocare in dubbio che egli ne avesse mai parlato con effettiva convinzione.
Molti hanno raccolto l’eredità di Falcone proclamandosi taluni eredi altri legatari. Pochi ne hanno tuttavia seguito l’esempio emulandone la costante dedizione alle istituzioni ed il più assoluto rispetto delle leggi.
Foto: RietiLife ©









 Rieti Life L'informazione della tua città
Rieti Life L'informazione della tua città